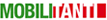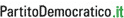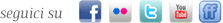Pubblicato su Lo Speciale
di Americo Mascarucci
Nulla di fatto ieri sera nel vertice del Terzo Polo. Le posizioni fra Azione e Italia Viva restano distanti e sebbene stasera sia previsto un nuovo incontro, fra Calenda e Renzi continua lo scontro a distanza con accuse reciproche che denotano chiaramente, prima che la rottura del rapporto politico, soprattutto quello umano e personale. Sono davvero in pochi a sperare che il progetto del partito unico vada in porto e possa durare. Ne abbiamo parlato con la giornalista e politologa Chiara Geloni, già direttrice di Youdem, il canale televisivo del Pd, oggi responsabile della comunicazione di Pierluigi Bersani.
Si aspettava sinceramente la rottura fra Renzi e Calenda?
“Sinceramente sì, me l’aspettavo. Non sono affatto stupita di ciò che sta avvenendo, era prevedibile”.
La rottura è determinata soltanto da ragioni economiche come sembrerebbe, o i motivi in realtà sono altri?
“Oltre il discorso economico penso ci sia soprattutto un problema caratteriale fra due prime donne che faticano a convivere e a fare passi indietro l’uno in favore dell’altro. Il vero nodo penso però sia soprattutto politico. C’è un evidente fallimento dell’operazione Terzo Polo nel suo complesso, cui si è probabilmente aggiunta la velleità di Renzi di mettersi a capo di un’operazione nuova, di fronte a possibili dinamiche che potrebbero aprirsi nel centrodestra ora che si fa strada la possibilità concreta che Silvio Berlusconi possa ritirarsi definitivamente dalla scena politica. Il progetto del Terzo Polo si sta dimostrando sempre più irrealizzabile, e lo hanno dimostrato chiaramente i risultati elettorali delle ultime regionali”.
Quindi non ritiene casuale il fatto che la crisi del Terzo Polo sia scoppiata contemporaneamente alle vicende personali che stanno riguardando Berlusconi?
“Non è affatto casuale, anche se è da tempo e ben prima che avvenissero le ultime vicende che Renzi sta guardando al centrodestra. Calenda deve quindi decidere cosa vuole fare. Intende procedere in assoluta solitudine a colpi di veti verso chiunque, o vuole iniziare a fare delle scelte politiche chiare? Penso sia arrivato per lui il tempo delle decisioni, quelle vere e che sia finita la stagione dei tatticismi”.
Quanto sta avvenendo nel campo centrista rafforza in qualche modo l’asse fra Pd e M5S nella costruzione di un’alternativa di centrosinistra?
“Non ho mai avuto dubbi sul fatto che questa sia la strada da percorrere. Il Pd deve cercare alleanze senza pensarsi autosufficiente. Mi pare che l’unico spazio reale sia nel dialogo con i 5Stelle, non in altre direzioni. La politica però non è fatta di geometrie. Se si riesce a creare un polo attrattivo realmente alternativo e competitivo alla destra, penso che i consensi potranno arrivare in tutte le direzioni, quindi anche dal centro. Spostandosi verso i 5Stelle quindi il Pd non è affatto destinato a perdere il voto dei moderati, ma costruendo una seria e credibile alternativa sarà in grado di intercettare consensi tanto alla sua destra che alla sua sinistra”.
Pensa che alla fine Renzi e Calenda riusciranno a ricucire lo strappo e a trovare un accordo? A sentire quelli di Italia Viva la volontà ci sarebbe tutta.
“La vedo molto complicata, mi sembra che i rapporti siano abbastanza deteriorati e che il progetto sia ormai superato dai fatti. Forse potrebbero prendere tempo e allungare il brodo per evitare lo scioglimento dei gruppi parlamentari e il passaggio al misto, ma la situazione mi sembra decisamente molto difficile da recuperare”.
Quindi vede per Renzi un futuro nel centrodestra e per Calenda un ritorno nell’orbita del centrosinistra?
“Mi sembra la realtà, più che un possibile scenario. Il problema sta nel concretizzare questa realtà da ambo le parti e capire come ciò potrà avvenire. Al momento c’è soltanto un tatticismo non dichiarato da parte di Renzi, che come si è visto dice una cosa ai giornali per poi con un tweet affermare l’esatto contrario. Manda avanti i suoi con dichiarazioni incendiarie e poi invita a non fare polemiche. Mentre da parte di Calenda si leggono affermazioni politiche che non si capisce bene se potranno trovare poi un’effettiva concretizzazione. Insomma, è tutto da decifrare”.
Ma lei vede possibili spazi per Renzi nel centrodestra? Forza Italia al momento sta saldamente al governo e anzi, nelle ultime settimane ha rafforzato la sua vocazione governista mettendo ai margini l’ala più critica verso la Meloni. Quindi?
“Penso che questi spazi in realtà li veda soltanto Renzi, ma è evidente come Italia Viva finora abbia lavorato molto più di sponda con il centrodestra che con il resto dell’opposizione. Basti pensare che hanno votato la commissione d’inchiesta sulla gestione del Covid nella versione leghista, ovvero con la richiesta di indagare sull’operato del governo Conte 2 e del ministro Speranza, assolvendo in partenza i presidenti delle regioni e strizzando anche l’occhio ai no vax. Mi pare evidente da quale parte guardi Renzi, che forse ha dimenticato di aver sostenuto quello stesso governo che oggi mette sotto accusa”.
Martedì sera Pierluigi Bersani su La7 ha evocato la storiella della rana e dello scorpione, invitando Calenda a stare bene in guardia per non finire come la rana. Ma chi è davvero la rana e chi è lo scorpione in questa storia?
“Bersani ha fatto quell’affermazione trovandosi davanti Calenda e naturalmente ha assegnato il ruolo dello scorpione a Renzi, ma questo non vuol dire che i torti siano soltanto da una parte. Non mi sento sinceramente di considerare Calenda una vittima viste le sue molte rigidità. Tuttavia è un dato di fatto di come i voti del Terzo Polo arrivino da Calenda, anche se poi Italia Viva ha il maggior numero di eletti. Il leader di Azione è quello che ci ha messo la faccia e ha raccolto il consenso, Renzi quello che ha beneficiato di più in termini di rappresentanza. Una situazione che a lungo andare diventa anche pesante da sostenere”.
Pensa che la rottura con Renzi e l’esigenza di ripensare la strategia possa spingere Calenda a superare le rigidità finora manifestate, ad esempio verso il dialogo con i 5Stelle?
“Non ho idea di cosa voglia fare. Se intenda fare politica o mera testimonianza. Fare politica vuol dire avere una visione e adoperarsi per raggiungere degli obiettivi, percorrendo la strada del confronto e del compromesso per costruire una coesione sociale. Se invece vorrà continuare ad andare soltanto nei talk show a propagandare le proprie convinzioni e appunto a testimoniare la propria esistenza si accomodi pure, ma così non farà politica”.
Pensa che Renzi possa ancora fare breccia fra i moderati del Pd ora che con la Schlein alla segreteria il loro ruolo si è ulteriormente indebolito?
“Non mi pare che la proposta renziana possa essere attrattiva per chi sta oggi nel Pd. Poi se qualcuno vorrà andare dove lo porta il cuore sarà libero di farlo, ma sinceramente non mi pare che al momento fra i dem siano nate posizioni così critiche da lasciar presagire abbandoni del partito. Sarebbe un calcolo a mio parere decisamente suicida”.
Come giudica le ultime scelte di Elly Schlein? Condivide le critiche di chi come Cuperlo accusa la neo segretaria di non aver saputo valorizzare le differenze?
“Elly Schlein è stata eletta per cambiare il Pd, quindi inutile chiederle di seguire vecchi schemi applicando compromessi e bilancini che hanno caratterizzato le precedenti stagioni. La vittoria della Schlein alle primarie ha segnato per il Pd l’ultima concreta possibilità di cambiare rotta e credo che abbia tutto il diritto di percorrere strade nuove e coerenti con la proposta politica con cui ha convinto gli elettori. Se poi queste scelte saranno davvero efficaci lo vedremo dai risultati, ma adesso non si può pretendere che Elly Schlein sia l’opposto di ciò che ha promesso di essere”.