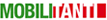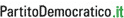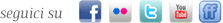di Francesco De Palo
“Un grande errore dare del filo a Renzi. Il Pd ha mostrato troppa equidistanza tra Conte e Italia Viva”. Lo dice a Formiche.net Chiara Geloni, già direttrice di Youdem e autrice del libro “Titanic. Come Renzi ha affondato la sinistra” (PaperFIRST, 2019) che scompone la crisi di governo nei suoi aspetti più intestini. Punto di partenza non è nell’oggi e nella possibile rottura di queste ore all’interno della maggioranza, ma nell’ultimo decennio quando il Pd ha mutato il proprio status anche personale, osserva. E sul Conte ter dice che…
Chi decide la linea nel Pd?
Naturalmente non ho dubbi che sia il segretario. Ma la domanda è resa legittima dal fatto che, in effetti, una delle non poche anomalie di queste giornate è che sembrano non esserci più neanche i luoghi, né i momenti in cui la politica dica qualcosa guardando le persone negli occhi. Nessuno ricorda un grande discorso pubblico o una grande intervista di Zingaretti attraverso i media o i canali social del partito a tutti gli uomini e le donne del Pd per raccontare cosa sta succedendo. Mi pare volersi affidare solo al retroscena, alle voci che filtrano o ai vicesegretari. Si arriva così al paradosso di Renzi che manda a Bettini, un autorevolissimo privato cittadino, le sue proposte sul Recovery.
Quanto conta realmente Nicola Zingaretti e quanto Dario Franceschini (e tutti gli altri) mentre al partito manca una fase assembleare, al netto dell’emergenza Covid?
Il momento assembleare manca per i motivi noti, ma al di là del Covid mancano i partiti. Manca una sede, un luogo, un giornale dove la linea del partito venga fuori come frutto non di un assemblearismo sessantottino, ma di una vera discussione tra veri leader che esprimono vere opzioni politiche. Non sono scandalizzata dal fatto che Zingaretti non sia l’uomo forte che decide senza discutere, quanto dal contrario: ovvero che i partiti non sono più luoghi in cui si discute. Il pluralismo è una bella cosa ma oggi nei partiti sembra un po’autoreferenziale perché si svolge tra membri del gruppo dirigente e non tra leadership che esprimono diverse sensibilità condivise. Parlo del Pd perché è stato l’ultimo dei partiti, ma vale anche per tutti gli altri.
Il Pd ha più volte detto chiaramente di non voler uscire dall’attuale schema di governo. Ma come pesa i rilievi al governo di Gentiloni e Sassoli sul Recovery?
Non credo sia giusto considerare qualsiasi opinione contraria come una critica. Il governo aveva elaborato una bozza sul Recovery che come tale era suscettibile di modifiche. Le critiche o i rilievi non vanno considerati come lesa maestà. Ciò che appare inaccettabile del Pd è la stata sua troppa equidistanza tra la posizione di Conte e quella di Italia Viva a tal punto che Renzi ha potuto dire, debolmente smentito, di parlare anche a nome del Pd. Il partito avrebbe dovuto essere più fermo nel difendere non Conte come persona ma come prospettiva di governo e come modo di starci, modus che non può essere rappresentato dal comportamento di IV, a prescindere dai torti e dalle ragioni. Non si sta in una maggioranza in questo modo, dando ultimatum ogni giorno, soprattutto dall’alto di una percentuale che, ovviamente rispetto, ma che in quanto tale non può pretendere di influire su tutta la linea.
È vero che un pezzo del Pd concorda nella tesi renziana?
Temo che il Pd abbia pensato che Renzi potesse rappresentare, con più libertà, un disagio presente tra i dem. È stato un grave errore, perché Renzi non è affidabile né controllabile, né può essere il rappresentante della cultura di governo Pd. Per cui non è interesse del Pd mantenere questa ambiguità, rispetto ad una fase che è già stata giudicata molto severamente dagli elettori.
Si poteva evitare di arrivare a questo punto, in un momento complicatissimo come quello in cui l’Italia si trova?
Sì. Ma sto ascoltando considerazioni sgradevoli anche sul piano umano: sono quasi dieci anni che ciò accade all’interno del Pd dove, prima ancora che una frattura politica, penso siano stati superati quei limiti umani che consentono la sopravvivenza di una comunità. Di questo sono stata testimone. Il Pd rifletta su questo aspetto, anche per valutare cosa accadrà nei prossimi giorni. Un governo può cadere e, molto laicamente, un’esperienza si può anche chiudere: ma c’è modo e modo di gestire una fase del genere e troppo spesso in passato il Pd ha gestito dei passaggi importanti calpestando le persone, con un messaggio sentimentalmente suicida rivolto agli elettori.
Bettini è un libero battitore oppure no?
Apprezzo il suo contributo e la sua intelligenza, ma non so definirlo. Certo non credo spetti a lui convocare assemblee. Il Pd per varie ragioni è rimasto senza padri nobili: oggi Bettini è l’unico che esercita un ruolo che spetterebbe forse ad una generazione che nei momenti difficili si mette a disposizione in maniera collettiva. Ricordo che all’epoca della segreteria Bersani egli si confrontava nei momenti più critici con un gruppo ristretto ma autorevole di dirigenti. Se oggi Zingaretti volesse farlo, avrebbe molte persone intelligenti da ascoltare. Ma osservo che il Pd è l’unico che non ha più ex segretari al suo interno, salvo Franceschini. Mi sembra una primizia assoluta.