Ho scritto questo per i giornali locali del gruppo l’Espresso (Il Tirreno, La Gazzetta di Mantova, Libertà, Il Mattino di Padova, Il Piccolo, La Gazzetta di Reggio, La Gazzetta di Modena, Il Messaggero Veneto, La Nuova Sardegna, La Nuova Venezia e altri).
Venerdì sera, mentre piazza della Signoria sfavillava dei riflettori delle dirette tv sul comizio in cui il premier annunciava la “rimonta bestiale” del Sì, nella Casa del popolo di Pontassieve, a pochi passi dalla strada in cui vive la famiglia Renzi, un centinaio di persone discuteva delle ragioni del No. Gente che ha pagato prezzi politici e professionali anche alti negli ultimi tre anni, e ha scelto di essere “contro” nonostante qualcosa da perdere e una pressione quasi minacciosa. Usciti dal partito o con un piede fuori ma che volevano ritrovarsi, ricostruire: “Siete stati eletti insieme, non come avversari”, dicevano a Filippo Fossati e Giovanni Paglia, deputati di Pd e di Sinistra italiana. Più lo sguardo al futuro che l’ansia per il risultato: “È vero che noi siamo pochi e in trincea nel partito. Ma io quando parlo con le persone normali, coi miei colleghi, al supermercato, trovo solo gente che vota No. E No convinto eh?”. E insieme, data la situazione, una certa passionale serenità: “Ma perché dicono che è stata una campagna brutta? È stata bella. A me piacciono sempre le campagne elettorali”.
Al di là degli aspetti più generali la battaglia per il No ha restituito a un pezzo di sinistra l’idea di una prospettiva; precisamente a quell’elettorato che il Pd com’è stato in questi tre anni non lo vota più, però non ha preso definitivamente altre strade. È gente che aveva votato Pd sempre, europee comprese, poi è rimasta prevalentemente a casa, nell’indifferenza più totale del gruppo dirigente. E domenica ha votato No, e “No convinto”. Si spiega anche così il fenomeno imprevisto di una partecipazione al voto a livelli da elezioni politiche. Anche in quelle “regioni rosse” dove il Sì ha riportato le uniche sofferte vittorie (e l’analisi provincia per provincia rivela un quadro molto più mosso di come può sembrare), la partecipazione è tornata ad essere la più alta d’Italia, come del resto era sempre stata: basta considerare la differenza tra il 37 per cento che partecipò alle regionali del 2014 in Emilia Romagna e il quasi 76 di domenica: oltre il doppio. E pur con tutto il gruppo dirigente locale schierato sul Sì la vittoria è stata di misura e limitata ad alcune province.
Oggi, di fronte alle dimensioni della sconfitta, è necessario riconoscere che se il Pd è ancora vivo lo deve alla lungimiranza di quella sua piccola parte che si è rifiutata di partecipare all’ordalia del “bastaunsì”, ha impedito che la vittoria del No fosse solo il trionfo di Grillo, Salvini e Berlusconi e ha presidiato la posizione di chi crede in un Pd diverso. Ancora una volta il referendum, come già le amministrative e le regionali, ha smentito le suggestioni alla “Partito della nazione”, dimostrando che i voti di destra non arrivano e non compensano quelli di sinistra che se ne vanno. Tra il paese e il Pd è successo qualcosa di grave in questi anni, e chi l’aveva visto si è preso del gufo rosicone e da ultimo del traditore. E invece aveva ragione.
Sarebbe un errore adesso pensare di risolvere tutto con una rapida resa dei conti congressuale. Anche al premier è probabilmente passata la voglia di chiedere un altro plebiscito. Ma soprattutto al partito non serve un’altra conta interna e autoreferenziale, bensì affrontare la sua difficoltà a capire la realtà e il suo isolamento nella società ricostruendo un campo credibile di centrosinistra. E d’altro canto, il Pd oggi non è in condizione di fare un congresso, anche se prima o poi dovrà farlo. Dopo tre anni di abbandono organizzativo e di totale asservimento alla comunicazione di palazzo Chigi non c’è più una base, non c’è un minimo di militanza, non c’è un pensiero condiviso a partire dal quale confrontarsi su diverse linee politiche. Dopo la stagione della rottamazione, il Pd ha bisogno di ricostruttori. Toccherebbe a Renzi, se avesse l’umiltà di mettersi a fare quello che (per sua stessa ammissione) non ha mai desiderato fare e non ha mai fatto, cioè il segretario del partito. Ma al punto in cui siamo è difficile. Anzi rischia di essere l’ostacolo più grande, sia che resti sia che se ne vada.


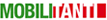


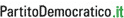
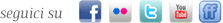
Solo cercando su Google Chiara Geloni, vista stamani su La7, di cui ho sempre apprezzato la lucidità di analisi, scopro che è la stessa persona di Chiaragione, di cui, per altre vie (blog) avevo notato l’arguzia di quel “a me m’hanno rovinato i cantautori”.
Congratulazioni per la lucidità… e per l’arguzia.
PS Della bellezza, non dico. Va da sè.
Grazie! 🙂
Ora è da capire se l’autocrate azzarderà fino in fondo cacciando la sinistra. A quel punto si terrà un partito solo per sé ed avremo uno scenario terrificante: la sfida elettorale fra il renzismo e il grillismo. Roba da capelli bianchi.