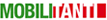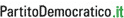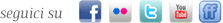Ho scritto questo per i giornali locali del gruppo l’Espresso (Il Tirreno, La Gazzetta di Mantova, Il Mattino di Padova, Il Piccolo, Il Centro, La Gazzetta di Reggio, La Gazzetta di Modena, Alto Adige, Il Trentino, Il Messaggero Veneto, La Nuova Sardegna, La Nuova Venezia, La Città di Salerno e altri).
A un mese circa dal ballottaggi, l’Assemblea nazionale del Pd si è riunita sabato con all’ordine del giorno Brexit e questioni internazionali. Innegabile che sia importante e necessario per un partito riflettere sui fatti storici e tragici di queste settimane. Resta però sullo sfondo la sensazione di un rimosso, di un’insufficienza. La sconfitta di giugno è stata archiviata da Matteo Renzi in direzione come un “risultato difficile da decifrare”. Nessuna analisi dal gruppo dirigente, solo retorici appelli al “dovere di cambiare”, un paio di “basta con le correnti” provenienti per lo più dai principali capicorrente e qualche rumor su rimpastini al vertice di organismi che negli ultimi anni nessuno ha riunito o considerato luoghi di decisione. Nelle città dove si è votato non ci sono stati scossoni, dimissioni, riunioni.
Qualche eccezione c’è, ma non fa che amplificare queste sensazioni. Il professore napoletano Eugenio Mazzarella, ex deputato del Pd, ha pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno un’analisi rigorosa del voto nella sua città. Ha guardato dentro quel numero già clamoroso della percentuale del partito – l’undici per cento! – analizzando i numeri reali e il peso concreto del Pd nella città, pari, calcolato l’astensionismo, al 5,5 per cento del corpo elettorale, che scende a circa la metà se si contano i voti di preferenza, cioè quelli “organizzati”. Si è chiesto che senso possa avere, in una realtà come questa, affrontare il referendum costituzionale puntando tutto sulla forza di mobilitazione del Pd e impostare la battaglia per il Sì su una clausola, peraltro impropria data la materia, di “disciplina”; e affrontare le prossime sfide, come già quella delle comunali, tutte in termini di posizionamento interno e di equilibri tra correnti che non rappresentano ormai che se stesse.
Un caso limite? Non è detto. Certo, si risponde spesso a chi avanza questi tentativi di analisi, i problemi mica nascono oggi. E infatti è vero. Anzi viene da pensare che ci sia, nella vicenda del partito che col suo segretario guida l’Italia, un grande rimosso che ne condiziona il presente. Un rimosso che non riguarda solo il Pd ma è diventato la narrazione collettiva della classe dirigente del paese, a partire dalla figura che allora lo rappresentava, al Quirinale.
Il senatore Giorgio Napolitano che invita energicamente Renzi a rivedere l’Italicum “adesso che c’è il tripolarismo” è lo stesso presidente Giorgio Napolitano che quattro anni fa (8 maggio 2012) rispose a una domanda dei giornalisti sul successo dei 5 Stelle alle amministrative che “di boom ricordo solo quello degli anni 60, altri non ne vedo”. Un anno dopo, la sua lettura fu coerente: lo stallo del 2013 andava risolto con la stessa logica di ciò che l’aveva causato, quella del governo Monti. Il sistema doveva fare blocco contro l’antisistema. I poli erano due, solo due e solo quei due, e dovevano mettersi insieme. Napolitano non volle guardare in faccia né il vincitore (rifiutandosi di dare l’incarico pieno a Pier Luigi Bersani) né lo sconfitto (che erano le larghe intese): e con lui l’Italia – poteri, network e giornali. Nel Pd questa lettura ebbe gioco facile, anche perché Bersani fu sconfitto nella notte dei 101 (e soprattutto in quella precedente) e si fece da parte. Divenne così il segretario che “aveva sbagliato il rigore a porta vuota” e la partita si chiuse.
Per il Pd, si conclude, ci voleva più storytelling, più forza comunicativa, più slide, più social network: così sì che avrebbe vinto. E il potere avrebbe fatto il resto, attirando il consenso come una calamita, come ai tempi della prima repubblica. Anzi il primo polo si sarebbe mangiato il secondo (che in realtà era il terzo), per il solo fatto di essere più giovane, più smart e più potente. E a regolare i conti al suo interno ci avrebbe pensato da solo, grazie a una nuova generazione e alla sua fame di gloria e di spazi, non solo televisivi.
Tre anni dopo, questa cura ha aggravato la malattia. Ora anche il vecchio presidente la vede, o comunque la teme. Ma senza un discorso di verità i tentativi di cambiare rotta appaiono ancor più scombinati e maldestri. Peggio, appaiono in malafede. E danno l’impressione che ancora una volta la risposta del sistema sia l’arroccamento. A pagare il prezzo più alto è proprio il Pd, e forse siamo solo all’inizio. Non ascoltare il popolo è un regalo ai populisti. Senza mescolare le questioni né le priorità, forse anche certe crisi internazionali si capirebbero meglio se si riflettesse su questo.